
Nato
a Fossombrone nel 1907, Giuseppe Occhialini si laureò in
Fisica
nel 1929 presso l’Università di Firenze, dove ebbe come
maestri
e colleghi due padri della Fisica del Novecento: Bruno Rossi e Gilberto
Bernardini. Occhialini (Beppo per gli amici) svolse la sua prima
attività di ricerca presso l’Istituto di Fisica di Arcetri
(Firenze) in un gruppo di giovani pieni di entusiasmo che passarono
dalla più tradizionale spettroscopia alle
attività
più moderne della Fisica Nucleare e dei Raggi Cosmici. Nel
1931,
all’età di ventiquattro anni, si recò al
Cavendish
Laboratory di Cambridge, dove lavorò sulla fisica dei raggi
cosmici impiegando le camere di Wilson (le cosiddette camere “a
nebbia”) e ottenne insieme a P.M.S. Blackett risultati che fanno parte
oggi della storia della Fisica. Nel 1933, mettendo per la prima volta
in pratica una metodologia innovativa da lui ideata, oggi nota con il
nome di trigger (che è alla base dei moderni esperimenti di
fisica nucleare e subnucleare), rivelò insieme a Blackett lo
sciame (shower) di elettroni e positroni prodotto dai raggi cosmici.
Blackett nel 1948 fu insignito del premio Nobel con la seguente
motivazione: “Per lo sviluppo della camera a nebbia di Wilson e le
scoperte che con essa si ottennero nel campo della fisica nucleare e
della radiazione cosmica”. Questa assegnazione, che escluse il creatore
dell’idea che aveva permesso l’ottenimento del grande successo
scientifico, ebbe luogo durante i primi anni della guerra fredda;
Occhialini non aveva mai fatto mistero delle sue idee politiche.
Blackett così si espresse: “Sono molto felice e orgoglioso
di
aver ricevuto il premio Nobel, ma lo sarei stato di più se
anche
Beppo lo avesse avuto con me”.
Nel 1937 Occhialini si
recò in Brasile presso l’Istituto di Fisica di San Paolo e
introdusse alla fisica dei raggi cosmici la prima generazione di fisici
brasiliani, tra i quali si distinse Cesare Lattes. Dopo la guerra, in
visita al Willis Laboratory di Bristol, Occhialini propose un nuovo
esperimento per la rivelazione delle radiazioni cosmiche ad altezze
elevate, dove la probabilità di osservare reazioni rare
risulta
più alta. I fisici di Bristol del gruppo di Cecil Powell
portarono così le loro emulsioni (tecnica fotografica) sul
Pic
du Midi in Francia, a 2.870 metri sul livello del mare, e dopo qualche
settimana le svilupparono. Trovarono allora tracce la cui accurata
analisi permise di stabilire che erano dovute ad una particella carica
che aveva la proprietà di decadere in una coppia di
particelle:
una - anch’essa carica ma più leggera, il muone - e una
neutra.
Alcuni dei più grandi fisici del secolo scorso, tra cui
Enrico
Fermi, pensarono allora che non ci fosse più niente da
scoprire
sulla struttura della materia. Infatti, con l’aggiunta della nuova
particella, chiamata mesone π (pione), si completava la conoscenza dei
costituenti elementari della materia e delle loro interazioni; si
poteva addirittura ventilare l’idea che il capitolo della fisica
nucleare fosse prossimo a chiudersi. In realtà, questa
scoperta
rivoluzionaria aprì un nuovo orizzonte, quello della fisica
subnucleare. Essa segna inoltre il passaggio da una fisica condotta con
strumentazione essenziale e mezzi poco costosi (una provvidenza per la
competitività europea negli anni devastanti della seconda
guerra
mondiale), alla big science dei grandi acceleratori di particelle e
delle grandi collaborazioni internazionali. Nel 1950 a Powell fu
attribuito il premio Nobel “per lo sviluppo del metodo fotografico
delle emulsioni nello studio dei processi nucleari e per le sue
scoperte nel campo dei mesoni”.
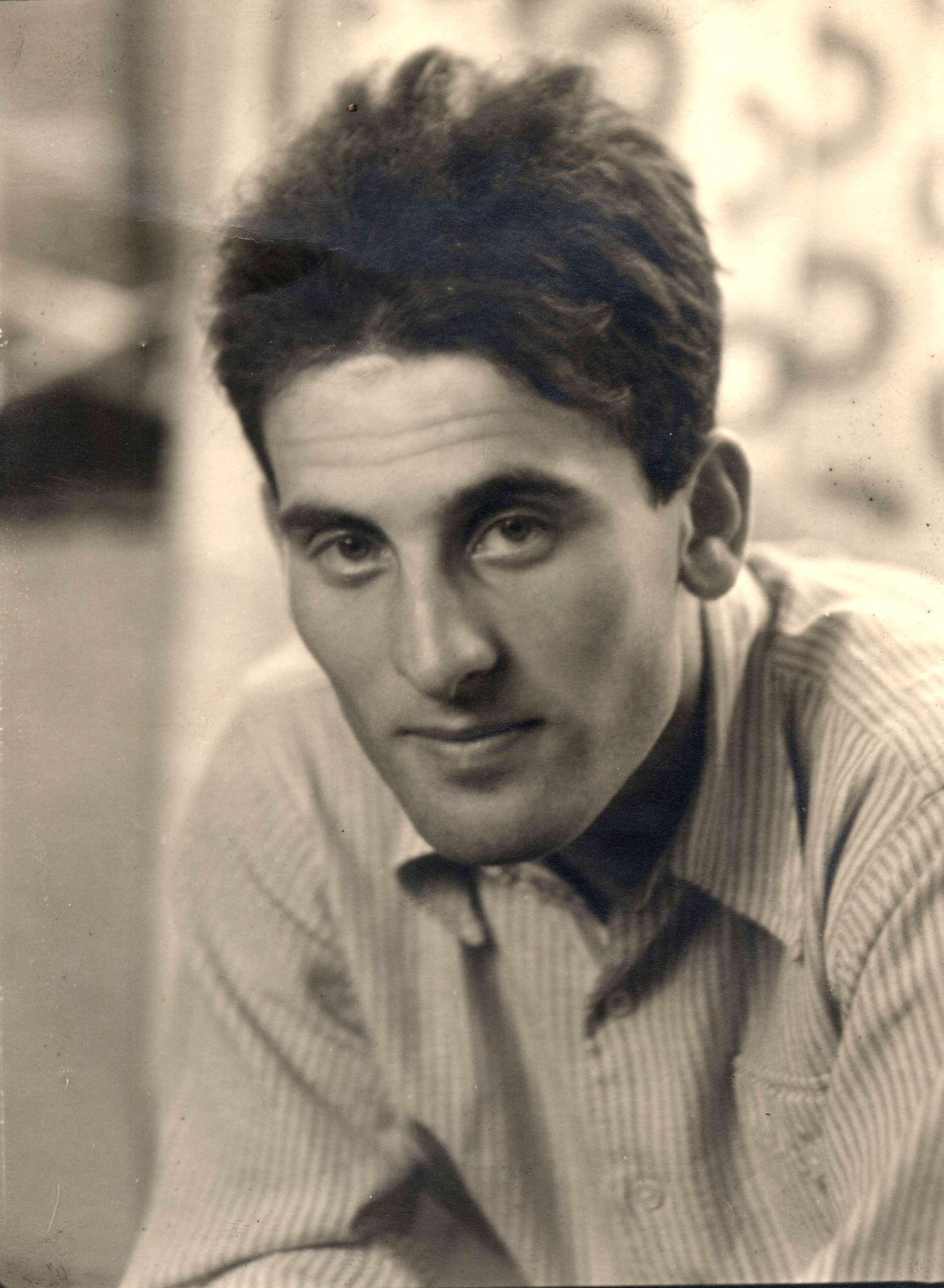
Professore
di Fisica nel 1950 a Genova, dal 1952 Occhialini ricoprì la
cattedra di Fisica Superiore dell’Università di Milano, dove
trascorse il resto della vita. In quegli anni rifondò la
Scuola
di Fisica cosmica italiana favorendo, insieme ad Edoardo Amaldi, lo
sviluppo dell’organizzazione per la ricerca spaziale europea, ora ESA
(European Space Agency). Tra i suoi allievi si laureò a
Milano
nel 1954 Riccardo Giacconi, premio Nobel per la Fisica nel 2002. Fu
infatti proprio Occhialini a suggerirgli di recarsi negli Stati Uniti
per lavorare nel campo dell’astronomia in raggi X con Bruno Rossi.
È intitolato al nome di Giuseppe Occhialini il satellite
Beppo-Sax, che sta fornendo informazioni di eccezionale importanza
sull’emissione da sorgenti del cosmo. Nel 1979 fu conferito a Giuseppe
Occhialini il Premio Wolf per la Fisica, “per i suoi contributi alle
scoperte della produzione delle coppie di elettroni e del pione
carico”. Il grande fisico morì a Parigi il 30 Dicembre 1993.
È generalmente accettato che l’esperimento di Cesare Lattes,
Hugh Muirhead, Giuseppe Occhialini e Cecil Powell, costituisce -
accanto a quello famoso di Marcello Conversi, Ettore Pancini e Oreste
Piccioni - il punto di partenza della moderna fisica delle alte
energie, sia per la pregnanza del risultato, sia per l’innovazione
nelle tecniche sperimentali adottate. Giuseppe Occhialini è
stato non solo un grande scienziato, che ha come pochi contribuito al
grande prestigio di cui la Fisica italiana gode nel mondo, ma anche un
grande maestro.
Alla
figura di Giuseppe Occhialini si può oggi guardare come ad
un
simbolo, tuttora attuale, del nascente spirito europeo. Essa incarna
quasi emblematicamente gli aspetti più positivi del ruolo e
dell’atteggiamento che l’Europa ha avuto nella seconda metà
del
ventesimo secolo in ambito mondiale: da un lato un’apertura spontanea e
quasi senza riserve all’influenza delle altre culture, particolarmente
quella del Nuovo Continente, dall’altro la volontà di
sostenere
il confronto con i ritmi di sviluppo consentiti dalle immense risorse
possedute oltreoceano, attraverso l’unione delle diverse forze
nazionali e la valorizzazione della propria grande tradizione.
Perfettamente inserita in questo clima politico-culturale si svolse la
vicenda umana e scientifica di Giuseppe Occhialini.
In terra straniera egli mise a frutto la
propria geniale creatività dando il contributo determinante
a
scoperte scientifiche nel campo della fisica delle particelle
elementari che per due volte valsero, purtroppo e ingiustamente solo ad
altri, il premio Nobel. Più volte si fece promotore e
ricoprì il ruolo di guida carismatica di progetti
scientifici
basati sulla cooperazione tra istituti internazionali, come la
collaborazione G-Stack, costituita, insieme alla moglie Constance
(“Connie”) Dilworth, per lo studio dei raggi cosmici tramite emulsioni
nucleari lanciate nello spazio a bordo di palloni aerostatici. Questa
iniziativa rappresentò un’occasione fondamentale per la
coagulazione dei Paesi europei e diede un fondamentale impulso alla
ricerca spaziale europea. Ne seguì infatti la nascita della
European Space Research Organization (ESRO), antesignana della attuale
European Space Agency (ESA). Occhialini fu inoltre tra i padri
fondatori del progetto COS-B della ESA, che fornì la prima
mappa
dettagliata delle sorgenti di raggi gamma della nostra galassia. Nel
1993 egli fu nominato membro onorario della European Physical Society.
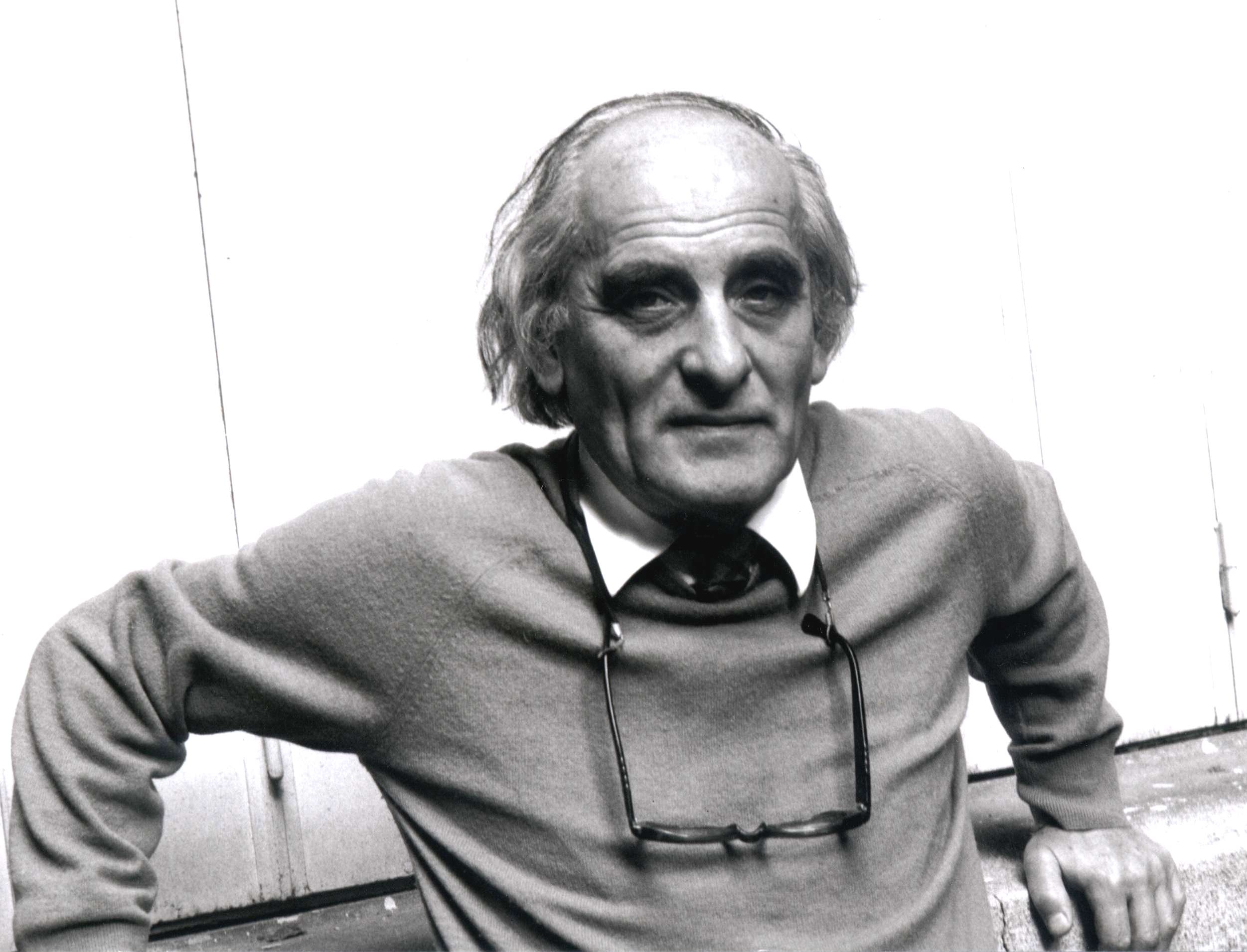
L’uomo
che lasciò in gioventù la sua Fossombrone per
studiare,
lavorare e vivere a Firenze, Cambridge, S. Paolo, Bristol, Bruxelles,
Genova, Milano, Boston, Ginevra, compiendo e dando impulso a importanti
scoperte e animando collaborazioni scientifiche internazionali,
rappresenta, in quanto scienziato italiano ed europeo, un esempio da
non dimenticare. Ciò è particolarmente vero oggi,
in un
momento in cui l’Europa si trova di fronte alla necessità di
una
crescita competitiva che non può prescindere da un rinnovato
impulso alla ricerca scientifica.
Verso la metà del
secolo, durante gli anni che videro il culmine della carriera
scientifica di Giuseppe Occhialini, stava prendendo corpo l’idea di
un’unità economica e politica dell’Europa. A cinque anni
dalla
fine del conflitto più sanguinoso della storia, l’allora
Ministro degli Esteri francese Robert Schuman proponeva di creare
un’Europa di pace. “La pace mondiale non potrà essere
salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che
la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale
può apportare alla civiltà è
indispensabile per il
mantenimento di relazioni pacifiche. […] Il governo francese propone di
mettere l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di
acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di
un’organizzazione alla quale possano aderire gli altri paesi europei.
La fusione delle produzioni di carbone ed acciaio assicurerà
subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima
tappa della Federazione europea…”.
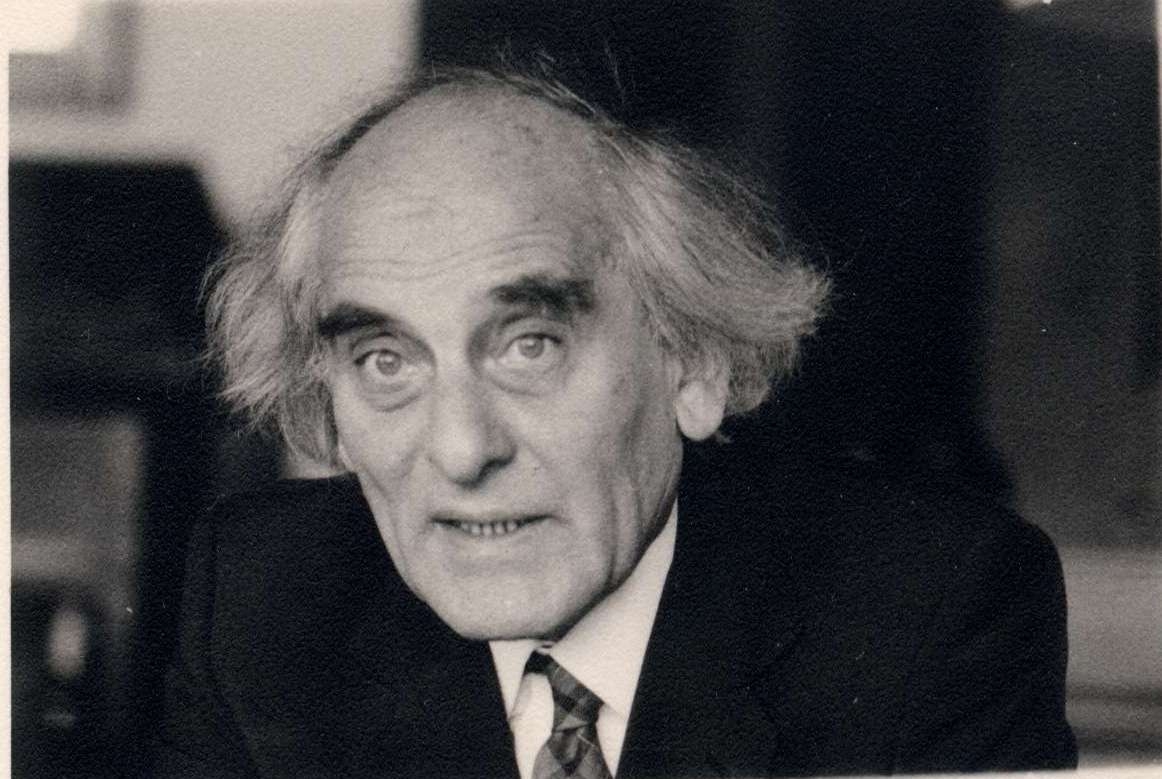
ll
concetto di federazione
europea ebbe tra le sue più naturali e
produttive
applicazioni
quelle in ambito scientifico, dove il lavoro congiunto degli stati
più importanti d’Europa, vincitori e vinti, portò
negli
anni successivi all’istituzione dei grandi laboratori europei. Con la
costruzione del CERN di Ginevra, nel 1954, il punto di riferimento
mondiale della “Big Science” era destinato a spostarsi dai famosi
centri di ricerca americani (Brookhaven, Berkeley, Fermilab) in Europa.
Furono poi realizzati nel 1962 lo European Southern Observatory (ESO),
nel 1963 la European Molecular Biology Organization (EMBO) e, un anno
dopo, la già citata ESRO insieme alla sua controparte
ingegneristica ELDO (European Launcher Development Organization). La
costituzione dell’ESRO rappresentava l’ingresso autorevole dell’Europa
nel settore della ricerca spaziale, a fianco del grande potere degli
Stati Uniti e dell’Unione Sovietica. Negli anni successivi vennero alla
luce la European Synchrotron Radiation Facility, l’Institut
Laue-Langevin, lo European Fusion Development Agreement e, a seguire,
svariate iniziative scientifiche e culturali: dalla matematica alla
psicologia sociale, alle geoscienze, alla sociologia. Nel 2004
è
stato raggiunto il numero di 52 organizzazioni europee.
A proposito di Beppo Occhialini così si sono espressi alcuni
grandi personaggi della Fisica:
- Gilberto Bernardini (ex direttore di
ricerca del CERN e primo presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare): “Un artista della strumentazione, un creatore di tecnologie,
un vero interprete della natura, dalle cui mani e dalle cui idee
scaturivano i mezzi per risolvere i problemi fondamentali della fisica”.
- Bruno Pontecorvo (Premio Lenin per la
Fisica): “Brindo non a Beppo, ma a tutti noi: se abbiamo la fortuna di
lavorare con lui, siamo sicuri di vincere un premio Nobel”.
- Leon Lederman (Premio Nobel per la
Fisica): “...Lattes, Occhialini, Powell. Occhialini, Beppo per gli
amici, era il più pittoresco del trio. Speleologo
e gran burlone, Beppo era la vera forza trainante del gruppo”.
- Carlo Rubbia (Premio Nobel per la
Fisica): “Un fisico di classe eccezionale che ha contribuito al
progresso delle conoscenze con risultati di grande rilievo. Beppo fu un
fisico nato, un tecnico profondo, un ricercatore con un’energia
illuminata e con una personalità magnetica, capace di
trasferire il suo entusiasmo a coloro che si trovavano intorno a lui.
Certamente avrebbe meritato il premio Nobel”.
- Cesare Lattes (fisico brasiliano), “Una
personalità attiva ma gentile, con grande coraggio fisico e
morale. Un amico leale e prezioso, una persona piena di considerazione.
Un grande e giovane romantico con i piedi per terra”.
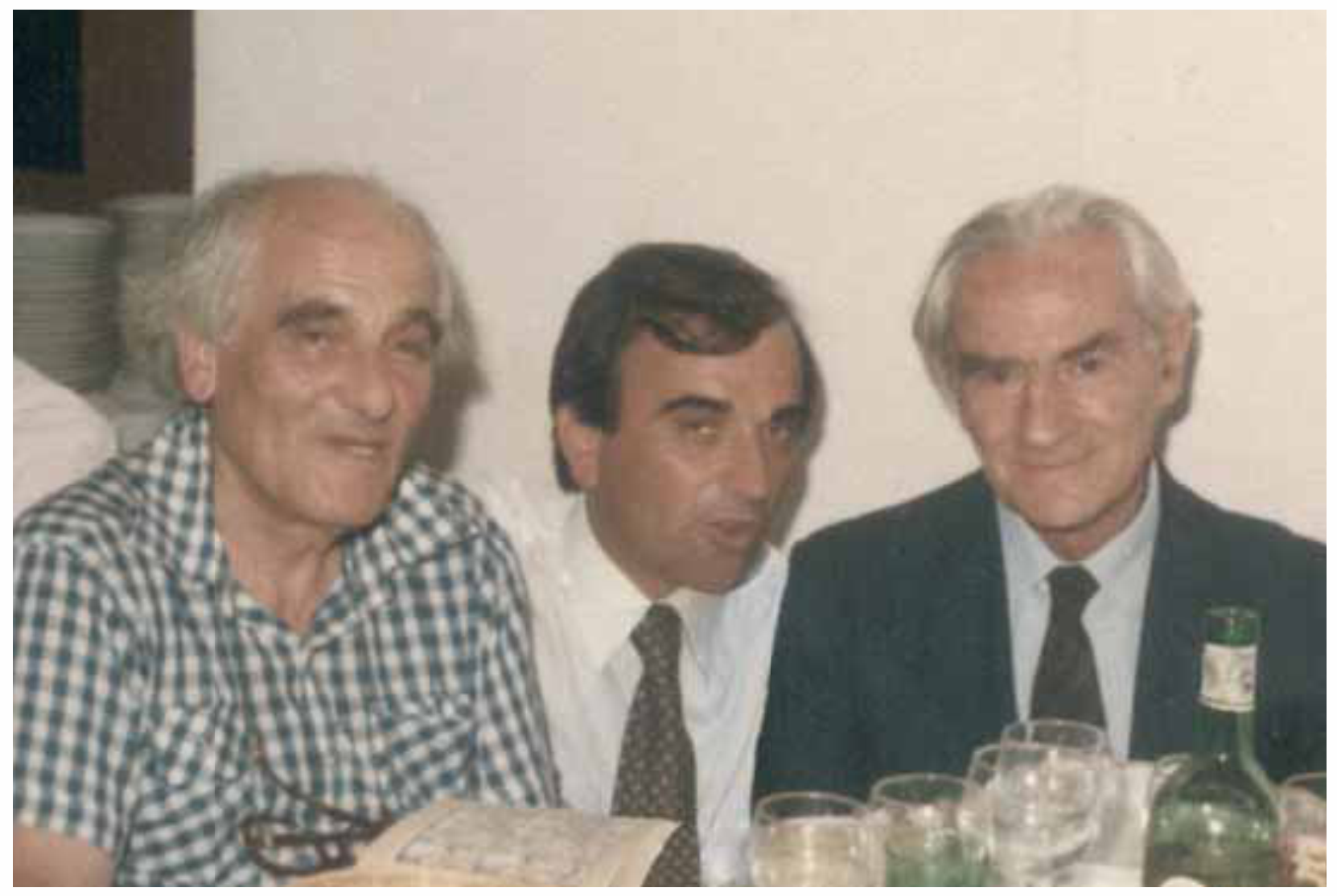
Da sinistra Giuseppe Occhialini, Antonio Vitale e Gilberto Bernardini
all’
International
Conference on Nuclear Physics, Firenze 1983.